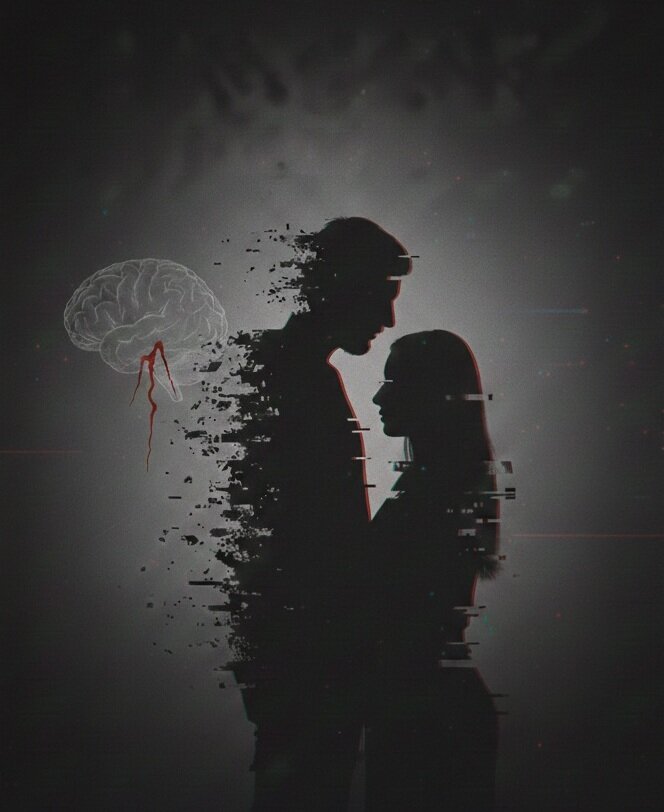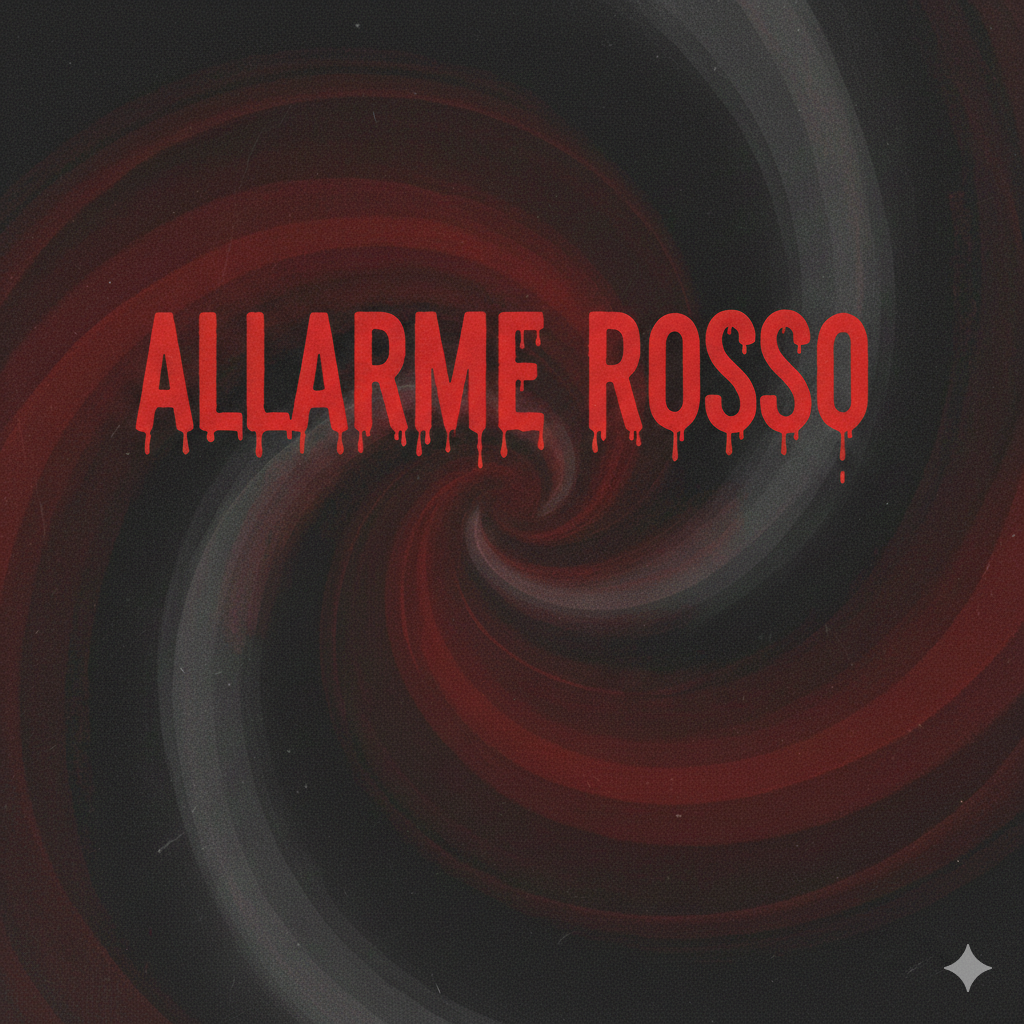Se ti sei perso alcuni articoli, puoi cliccare sulle parole chiave che trovi sotto il titolo di ogni articolo. Clicca sulla parola che rappresenta il tema che vorresti approfondire. Ricorda che siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione.
L'Eco delle ferite invisibili: un'analisi psicotraumatologica relazionale giudiziaria del caso Elia Del Grande
A cura di:
Massimo Lattanzi, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD. Tiziana Calzone, Psicologa, Psicoterapeuta
(Direzione Scientifica AIPC - Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia e CIPR - Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale)
Abstract
Questo articolo analizza il caso di Elia Del Grande, autore del triplice omicidio dei suoi familiari a Cadrezzate nel 1998, attraverso la lente teorica della Psicotraumatologia Relazionale Giudiziaria. Adottando il quadro metodologico dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC) e del Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR), e basandosi sui contributi di Lattanzi, Calzone, van der Hart, Nijenhuis, Steele e Bowlby, l'analisi si discosta da un'interpretazione puramente criminologica per esaminare l'eziologia del comportamento violento. Si postula che l'intera traiettoria di vita di Del Grande, dal parricidio ai reati successivi fino alla recente fuga, rappresenti una sequenza coerente di acting-out dissociativi, radicati in un trauma relazionale complesso e non elaborato, originato in un contesto di attaccamento disorganizzato. L'articolo decostruisce gli eventi chiave — l'infanzia, la crisi a Santo Domingo, l'atto omicida e la successiva carriera istituzionale — come manifestazioni della scissione della personalità in una Parte Apparentemente Normale (PAN) e una Parte Emozionale (PE). Si conclude che la risposta del sistema giudiziario, non essendo informata sul trauma, ha fallito nel trattare le cause sottostanti della violenza, perpetuando un ciclo di disregolazione e ri-traumatizzazione. L'articolo evidenzia la necessità di un paradigma giudiziario che integri i principi della psicotraumatologia per una più efficace prevenzione e riabilitazione.
Introduzione: Oltre l'atto, verso l'origine
Il caso di Elia Del Grande, autore della "strage dei fornai" avvenuta a Cadrezzate il 7 gennaio 1998 (Giovannelli, 2023), rappresenta un esempio paradigmatico di come l'acting-out violento possa essere l'espressione finale e catastrofica di una vita intera di traumi relazionali non elaborati. Questo articolo si propone di superare la cronaca sensazionalistica per fornire un'analisi strutturale e approfondita della traiettoria di Del Grande, dai suoi anni evolutivi fino alla recente fuga da una casa-lavoro il 30 ottobre 2025 (Immagine fornita dall'utente).
Il quadro metodologico adottato per questa analisi si basa esclusivamente sulla lente teorica della Psicotraumatologia Relazionale, così come definita dall'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC) e dal suo Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR) (AIPC, 2025a; AIPC, 2025b). Nello specifico, si applica il modello della Psicotraumatologia Relazionale Giudiziaria, una disciplina che applica i principi della psicotraumatologia al contesto giuridico e forense. Questo approccio si occupa della valutazione dei sintomi post-traumatici in ambito civile e penale, analizzando come le esperienze traumatiche, specialmente quelle infantili, influenzino la disregolazione emotiva e la narrazione degli eventi, con implicazioni dirette sulla valutazione dell'imputabilità, l'attendibilità della testimonianza e il rischio di recidiva (Studio RiPsi, 2026).
L'analisi attingerà in modo sostanziale ai contributi fondamentali di Massimo Lattanzi e Tiziana Calzone (2025), interpretando le azioni di Del Grande non come scelte criminali isolate, ma come i sintomi prevedibili, sebbene tragici, di un Sé profondamente fratturato, forgiato in un crogiolo di attaccamento disfunzionale (Bowlby, 1988).
La tesi centrale di questo elaborato è che l'intero percorso di vita di Elia Del Grande — includendo il parricidio, i reati successivi e la fuga finale — costituisce una narrazione coerente di un trauma complesso irrisolto. Ogni evento rappresenta una riattivazione di meccanismi di sopravvivenza primari (attacco, fuga, congelamento) radicati in ferite relazionali precoci, che il sistema giudiziario ha costantemente frainteso e fallito nel trattare in modo adeguato.
Ascolta il podcast sul Canale AIPC Editore su Spotify MENTE|CRIMINE|TRAUMA,“L'Eco delle ferite invisibili: un'analisi psicotraumatologica relazionale giudiziaria del caso Elia Del Grande", clicca sul link: https://open.spotify.com/episode/6FXRDce4cAF2Gz5h03UWBj?si=sCNcDBEGTvGthRie1OeI5Q
Sezione 1: L'architettura del trauma: ipotesi evolutive e dinamiche familiari
1.1 Il paradosso del caregiver nel sistema familiare Del Grande
Sebbene i dettagli specifici sull'infanzia di Del Grande siano limitati, il modello AIPC/CIPR permette di costruire una solida ipotesi basata sugli esiti osservabili. Questo quadro teorico postula che le più gravi psicopatologie originino in un ambiente in cui la figura di accudimento è simultaneamente fonte di bisogno e fonte di paura (Liotti, 2001). La famiglia Del Grande, nota pubblicamente come "fornai" di successo, presentava probabilmente una facciata di normalità e operosità che mascherava un cronico fallimento della sintonizzazione emotiva (Lattanzi & Calzone, 2025). Questo genera un conflitto "affettivo paradossale", costringendo il bambino a un dilemma irrisolvibile: per sopravvivere, deve cercare la prossimità con la stessa fonte del suo terrore.
Questa dinamica conduce allo sviluppo di uno stile di attaccamento disorganizzato, caratterizzato da comportamenti contraddittori e una profonda confusione interna, in cui l'altro viene vissuto contemporaneamente come rifugio e pericolo (Main & Solomon, 1990). La nota "fragilità psichica" di Del Grande (Giovannelli, 2023) è il termine clinico che descrive l'esito di una tale storia evolutiva. La facciata pubblica della famiglia, incentrata sul lavoro e sul successo materiale, suggerisce un sistema che privilegia la produttività e l'apparenza rispetto all'espressione e alla validazione emotiva. Un ambiente di questo tipo è un noto terreno fertile per l'incuria emotiva, una forma di trauma relazionale sottile ma potente, in cui i bisogni autentici di un bambino vengono costantemente ignorati o invalidati (Lattanzi & Calzone, 2025). Le vulnerabilità di un figlio come Elia diventano una minaccia per questa immagine e vengono quindi soppresse anziché comprese, creando le condizioni esatte per un trauma relazionale cronico.
1.2 La formazione di un sé fratturato: la dissociazione strutturale in Elia Del Grande
Di fronte a stati emotivi intollerabili, la personalità si frammenta come meccanismo di sopravvivenza. Questo fenomeno è spiegato dalla Teoria della Dissociazione Strutturale (van der Hart, Nijenhuis, & Steele, 2011). È possibile ipotizzare che Del Grande abbia sviluppato:
Una Parte Apparentemente Normale (PAN): Questa parte è orientata al funzionamento quotidiano — lavorare, socializzare, tentare di conformarsi. Tuttavia, la sua funzione primaria è l'evitamento dei ricordi traumatici e delle emozioni associate. Questa parte è "anestetizzata" (numbed) e si sforza di mantenere una parvenza di controllo (van der Hart et al., 2011).
Una Parte Emozionale (PE): Questa parte è "congelata" al momento del trauma e custodisce tutte le emozioni grezze e non elaborate (terrore, rabbia, vergogna) e le risposte difensive di sopravvivenza (attacco, fuga, congelamento) (van der Hart et al., 2011). La PE contiene gli stati del Sé "non-me", ovvero sensazioni percepite come illegittime, fonte di vergogna e indicibili (AIPC, 2016).
I suoi primi problemi comportamentali, come la diserzione dal servizio militare dopo il furto di una pistola (Giovannelli, 2023), possono essere interpretati come "intrusioni" precoci dello stato disregolato della PE nel tentativo della PAN di funzionare. Questi non sono semplici reati, ma marcatori diagnostici critici del suo stato interno. La diserzione è una risposta di "fuga" da un sistema rigido e autoritario che probabilmente rispecchiava le dinamiche oppressive della sua famiglia. Il furto di un'arma è un tentativo disperato da parte della PE di acquisire un senso di potere e agentività in un mondo percepito come soverchiante e minaccioso.
1.3 La vergogna come organizzatore silenzioso
Nei casi di trauma interpersonale, la vergogna — e non la paura — è l'emozione dominante e più corrosiva (Wilson, 2022). Essa funziona come una strategia di sopravvivenza primitiva, un "freno interiorizzato" che insegna al bambino a sopprimere i propri bisogni e le proprie azioni per evitare punizioni o rifiuti da parte di un caregiver non sicuro (Schore, 2008, cit. in Wilson, 2022). Si può dedurre che l'identità di Del Grande fosse organizzata attorno a un nucleo di vergogna tossica. La sua successiva aggressività e le sue "spacconerie" (Giovannelli, 2023) sono difese classiche contro questo sentimento insopportabile di indegnità. La rabbia serve a mascherare il dolore sottostante e a generare una sensazione fugace e illusoria di potenza (Wilson, 2022). Questa vergogna è il "segreto senza parole" della parte "non-me" del Sé (AIPC, 2016).
Sezione 2: Il catalizzatore traumatico: Santo Domingo e la riattivazione del conflitto relazionale
2.1 Il "Paradosso del partner" e la ricerca di una patria emotiva
La decisione della famiglia di mandare Elia a Santo Domingo fu un "errore strategico" (Giovannelli, 2023) di proporzioni catastrofiche. Da una prospettiva psicotraumatologica, fu un atto di estrusione, un modo per allontanare il "problema" anziché affrontarlo. Questo atto di allontanamento fisico da parte del sistema familiare, motivato probabilmente dalla preservazione della propria immagine pubblica piuttosto che dal benessere di Elia, ha rappresentato un profondo atto di incuria, quasi un abbandono, che ha precipitato il suo crollo psicologico.
A Santo Domingo, la relazione di Del Grande con Raisa diventa il dramma centrale. Secondo il "Paradosso del Partner" di Lattanzi e Calzone (2025), gli individui con storie di trauma sono inconsciamente attratti da partner che "parlano la stessa lingua traumatica". Raisa, descritta come una giovane prostituta (Giovannelli, 2023), rappresentava probabilmente una "patria emotiva": una dinamica relazionale basata su vulnerabilità, transazionalità e instabilità che risuonava con il suo mondo interiore. L'intensità del suo attaccamento ("perde completamente la testa" [Giovannelli, 2023]) è caratteristica di un legame traumatico, non di un attaccamento sano.
2.2 Disregolazione affettiva e collasso della PAN
Allontanato dalla struttura familiare contenitiva (sebbene disfunzionale), la PAN di Del Grande perse la sua impalcatura esterna. La sua successiva "vita di totale dissolutezza", caratterizzata da armi e aggressività (Giovannelli, 2023), è una manifestazione da manuale di grave disregolazione affettiva — il sintomo principale del trauma complesso (van der Hart et al., 2011). Egli oscillava tra iper-attivazione (attacco/fuga: aggressività, paranoia) e ipo-attivazione (congelamento: probabile uso di sostanze, anestesia emotiva) senza alcuna capacità di autoregolazione. Ciò dimostra il completo fallimento della PAN nel gestire le soverchianti intrusioni della PE.
2.3 Il rifiuto familiare come ri-traumatizzazione acuta
Al suo ritorno, il rifiuto della famiglia di discutere della sua relazione con Raisa (Giovannelli, 2023) fu una riattivazione del trauma primario: l'invalidazione della sua realtà emotiva. Il confronto finale, la sera del 6 gennaio 1998, fu l'innesco definitivo. Il "disprezzo" espresso dalla famiglia e, in modo critico, l'insulto razzista del fratello (Giovannelli, 2023), costituirono una ri-traumatizzazione acuta e travolgente. Non si trattò di un semplice litigio, ma di una minaccia esistenziale al suo Sé già frammentato, una conferma finale e violenta della sua indegnità e "alterità" all'interno della sua stessa famiglia. L'insulto razzista non fu solo un'offesa, ma l'annientamento simbolico del suo oggetto di attaccamento prescelto (Raisa) e, per estensione, di Elia stesso. Per la PE, che custodisce il trauma centrale dell'essere invalidato, questa fu la conferma definitiva della sua paura più profonda: essere irrimediabilmente "sbagliato" e meritare la distruzione. Questo scatenò la risposta di "attacco" nella sua forma più estrema e letale.
Sezione 3: L'atto dissociativo: decostruire l'omicidio
3.1 La violenza come linguaggio della parte emozionale (PE)
Il triplice omicidio del 7 gennaio 1998 deve essere compreso come un catastrofico "acting-out" avvenuto in uno stato dissociativo. Il confronto ri-traumatizzante con la famiglia causò il collasso completo della PAN e una totale presa di potere da parte della PE (van der Hart et al., 2011). La "furia" descritta nelle cronache (Giovannelli, 2023) è la rabbia grezza e indifferenziata della PE, soppressa per anni. La violenza non fu diretta in modo calcolato contro tre individui distinti, ma contro l' "unità familiare" come unica fonte del suo trauma di una vita. Questo si allinea con la comprensione dell'AIPC/CIPR della violenza come "narrazione del trauma" (AIPC, 2025c), una disperata comunicazione non verbale di un dolore insopportabile. La natura stessa del gesto, una "strage" che implica una violenza estrema e personale, punta direttamente alla risposta di "attacco" della PE, un'espressione della rabbia incarnata che caratterizza questa parte dissociata.
3.2 L'assenza di perizie psichiatriche e l'ipotesi dell'amnesia dissociativa
Sebbene non siano disponibili negli atti di ricerca specifiche perizie psichiatriche disposte dal tribunale, il quadro AIPC/CIPR fornisce un potente modello esplicativo. La natura del crimine suggerisce fortemente uno stato di dissociazione, potenzialmente accompagnato da amnesia per l'evento stesso, un fenomeno ben documentato in crimini di estrema passionalità o trauma (UNID, 2024). In un tale stato, la coscienza è gravemente alterata e le azioni diventano automatiche, guidate da circuiti di sopravvivenza primitivi (UNID, 2024). L'individuo non ha il controllo delle proprie funzioni cognitive. Una perizia formale condotta attraverso questa lente avrebbe probabilmente identificato un Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso (DPTS-C) con gravi caratteristiche dissociative, piuttosto che un semplice disturbo di personalità o una malvagità calcolata.
3.3 La confessione immediata come ritorno della PAN
La confessione rapida e non forzata di Del Grande alle autorità svizzere al momento del suo arresto (Giovannelli, 2023) è altamente significativa. Può essere interpretata come la ri-emersione della "Parte Apparentemente Normale" (PAN). La PE, dopo aver scaricato il suo travolgente carico emotivo, si è ritirata, lasciando la PAN a confrontarsi con le terrificanti conseguenze. La PAN non "possiede" le azioni della PE; le vive come aliene e orribili. La confessione è quindi un tentativo da parte della PAN di dare un senso all'incomprensibile e di ripristinare una qualche parvenza di ordine in una realtà frantumata. La sequenza degli eventi segue un classico schema di risposta al trauma: prima la risposta di "attacco" (gli omicidi), seguita immediatamente dalla risposta di "fuga" (il tentativo di raggiungere la Svizzera). La sua cattura ha interrotto questa sequenza, portando alla ri-emersione della PAN e alla successiva confessione.
Sezione 4: L'eco istituzionale: Giustizia, detenzione e il trauma Irrisolto
L'intera storia del caso, se analizzata attraverso la lente psicotraumatologica dell'AIPC/CIPR, rivela una continua e coerente interazione tra eventi esterni e dinamiche psicologiche interne. Prima del 1998, la nota "fragilità psichica" di Del Grande e la sua diserzione militare (Giovannelli, 2023) possono essere interpretate come manifestazioni di un Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso derivante da un ipotetico trauma relazionale cronico; si trattava delle prime intrusioni della Parte Emozionale (PE) e delle sue risposte di sopravvivenza, in particolare la "fuga".
Nel 1997, la decisione della famiglia di mandarlo a Santo Domingo, dove condusse una "vita dissoluta" (Giovannelli, 2023), agì come un'estrusione dal sistema familiare. Ciò portò al collasso della sua Parte Apparentemente Normale (PAN) a causa di una grave disregolazione affettiva in un ambiente non strutturato. Il confronto con la famiglia il 6 gennaio 1998, culminato in un insulto razzista (Giovannelli, 2023), costituì una ri-traumatizzazione acuta, un annientamento simbolico del Sé che innescò il collasso catastrofico della PAN e la totale presa di potere da parte della PE.
Il triplice omicidio del 7 gennaio 1998 (Sky TG24, 2025) fu l'acting-out di "attacco" della PE, una scarica dissociativa della rabbia traumatica accumulata. La sua immediata fuga in Svizzera e la successiva confessione (Giovannelli, 2023) rappresentano la risposta di "fuga" della PE, seguita dalla ri-emersione della PAN inorridita, che confessò per ripristinare un ordine.
Il processo, iniziato nell'ottobre 1998 con una condanna a 30 anni (Giovannelli, 2023), mostra come il sistema legale abbia interpretato l'atto dissociativo come omicidio premeditato, focalizzandosi sul comportamento ("il cosa") piuttosto che sull'eziologia ("il perché"). I 25 anni di prigione scontati fino al 2023 (Immagine fornita dall'utente) sono trascorsi senza una terapia specifica per il trauma, lasciando le strutture traumatiche sottostanti (scissione PAN/PE, disregolazione) non trattate e probabilmente rinforzate.
Dopo il rilascio, i furti e le molestie ai vicini (Immagine fornita dall'utente) sono stati una prevedibile conseguenza della disregolazione, con la PAN incapace di far fronte alla vita e l'acting-out come sintomo del trauma ancora attivo. Di conseguenza, prima dell'ottobre 2025, è stato dichiarato "socialmente pericoloso" e inviato in una casa-lavoro (Immagine fornita dall'utente), una risposta non informata sul trauma che ha ri-etichettato il sintomo ("pericolosità") e prescritto ulteriore confinamento, di per sé un innesco. Infine, la sua fuga il 30 ottobre 2025 (Immagine fornita dall'utente) è una classica risposta traumatica di "fuga", innescata dalla minaccia percepita dal controllo e dal confinamento della struttura.
4.1 Il processo giudiziario e l'etichetta di "socialmente pericoloso"
La condanna a 30 anni e la successiva gestione legale di Del Grande esemplificano un sistema fondamentalmente non informato sul trauma. I reati post-rilascio di furto e molestie non sono la prova di una "mente criminale" incorreggibile, ma i sintomi prevedibili di un individuo privo di abilità per la regolazione emotiva o per un sano funzionamento relazionale (AIPC, 2025b; R57). La dichiarazione di "pericolosità sociale" è un errore diagnostico critico. Il sistema identifica correttamente il rischio, ma ne attribuisce erroneamente la causa. Vede il pericolo, dove uno psicotraumatologo vedrebbe una profonda disregolazione. La soluzione prescritta — una "casa-lavoro" — è quindi contro-terapeutica, poiché re-impone un ambiente controllante e restrittivo che è di per sé un potente innesco traumatico.
4.2 La fuga come prevedibile risposta al trauma
La fuga di Del Grande il 30 ottobre 2025 non dovrebbe essere vista come un astuto piano criminale. È l'esito logico e prevedibile del collocare un individuo con un trauma complesso non trattato di nuovo in una situazione che mima l'impotenza e la mancanza di agentività del suo trauma originale. L'atto di "scavalcare il muro" è una messa in scena letterale e disperata della risposta di sopravvivenza di "fuga", innescata dalla minaccia percepita dall'istituzione. Il suo sistema nervoso, ancora bloccato al 1998, ha fatto ciò che è programmato per fare quando si sente minacciato: fuggire. L'intero percorso post-omicidio mostra come il sistema legale e carcerario possa diventare un agente di ri-traumatizzazione. Concentrandosi esclusivamente sulla punizione e sul contenimento, ignora la causa profonda della violenza. Ogni passo — la lunga detenzione senza una terapia adeguata, l'etichetta di "pericoloso", il nuovo confinamento — serve a rafforzare la visione del mondo della PE, secondo cui il mondo è un luogo minaccioso e le figure autoritarie sono pericolose.
Conclusione: dalla punizione alla riparazione
La vita di Elia Del Grande è un devastante caso di studio dei principi fondamentali dell'AIPC/CIPR. Illustra come un trauma relazionale cronico e non affrontato possa portare a un Sé frammentato, organizzato attorno alla vergogna e gestito attraverso la dissociazione. Mostra come eventi successivi della vita possano agire da potenti inneschi, portando a una violenza catastrofica, e come una risposta sociale non informata sul trauma possa perpetuare un ciclo di disregolazione e acting-out.
La tragedia di questo caso risiede nella sua prevedibilità e, quindi, nella sua potenziale prevenibilità. Un intervento guidato dal modello AIPC/CIPR avrebbe seguito un approccio fasico (van der Hart et al., 2011) :
Stabilizzazione e Sicurezza: La prima priorità non sarebbe stata la punizione, ma la creazione di una relazione terapeutica sicura e l'insegnamento di abilità di regolazione emotiva e fisiologica, utilizzando potenzialmente biofeedback e neurofeedback (AIPC, 2025d).
Elaborazione delle Memorie Traumatiche: Solo una volta raggiunta la stabilità, il lavoro terapeutico sarebbe iniziato sull'attenta elaborazione e integrazione delle memorie traumatiche custodite dalla PE, permettendo alla PAN di comprendere e "appropriarsi" dell'intera storia di vita.
Integrazione e Riconnessione: La fase finale si sarebbe concentrata sull'elaborazione del lutto per il passato, sullo sviluppo di sane abilità relazionali e sulla costruzione di una nuova narrazione di vita non più definita dal trauma.
Il caso di Elia Del Grande è un duro monito che "il carcere non basta" (ONS, 2022). Per i crimini radicati in un trauma profondo, la giustizia non può essere raggiunta solo attraverso la punizione. La vera prevenzione e riabilitazione richiedono un approccio scientifico, compassionevole e informato sul trauma, che cerchi di guarire le ferite che alimentano la violenza.
Riferimenti bibliografici
AIPC. (2016). La relazione terapeutica e il cambiamento. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
AIPC. (2025a). Psicotraumatologia relazionale: una definizione integrata. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
AIPC. (2025b). Rubrica: Lo psicotraumatologo relazionale del CIPR risponde. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
AIPC. (2025c). Due tombe: Quando il dolore sepolto uccide ancora. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
AIPC. (2025d). Prevenire la Violenza con la Scienza: Psicotraumatologia per ridurre le recidive. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books. (Trad. It. Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento. Raffaello Cortina Editore, 1989).
Giovannelli, M. (2023). Ep.2 - La mail che fece luce sul delitto di Cadrezzate. Varese News Rewind [Video]. YouTube.
Lattanzi, M., & Calzone, T. (2025). La bolla traumatica e il paradosso del partner. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
Liotti, G. (2001). Le opere della coscienza. Psicopatologia e psicoterapia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista. Raffaello Cortina Editore.
Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121–160). University of Chicago Press.
ONS. (2022). Osservatorio Nazionale sullo Stalking: "Il carcere non basta". StopStalkingItalia.it.
Sky TG24. (2025, 1° novembre). Sterminò la famiglia nel 1998, Elia Del Grande fugge da comunità.
Studio RiPsi. (2026). Psico-traumatologia clinica: Valutazione giuridica e forense delle sindromi post traumatiche.
UNID. (2024). Delitto di Cogne: Analisi Criminologica. Unidprofessional.com.
van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2011). Fantasmi nel sé. Trauma e trattamento della dissociazione strutturale. Raffaello Cortina Editore.
Wilson, I. (2022). Il trauma relazionale: qual è il ruolo della vergogna? IPSICO.it.