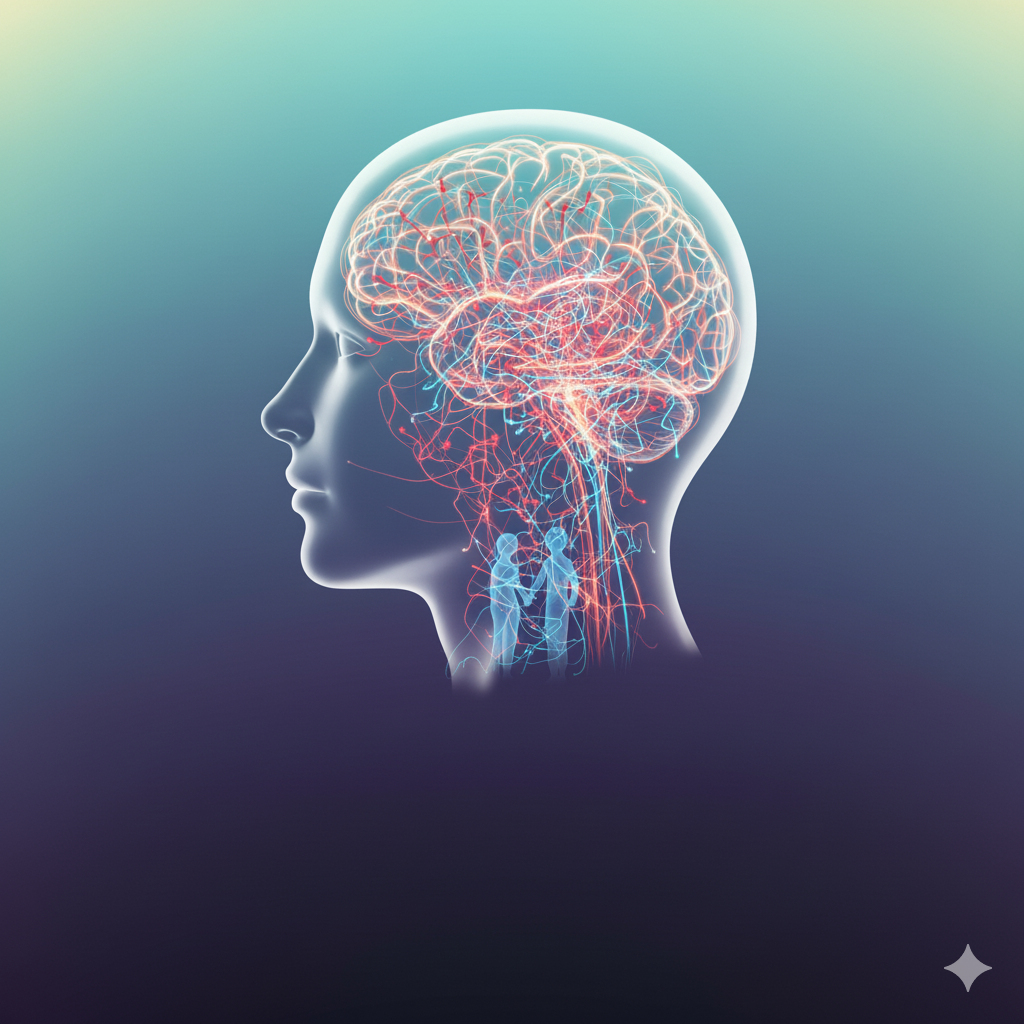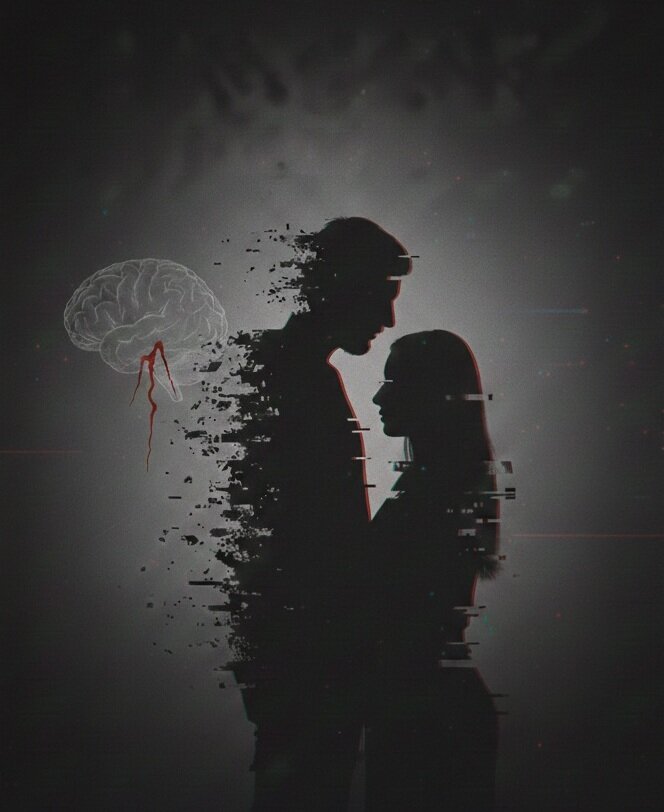L'Impronta neurale del trauma relazionale: una rilettura neuroscientifica attraverso il modello della psicotraumatologia italiana
Autori: Massimo Lattanzi¹²³ & Tiziana Calzone¹²³
¹ Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC) ² Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR) ³ Osservatorio Nazionale Omicidi Familiari (ONOF)
Abstract
Il presente lavoro si propone di integrare le recenti scoperte nel campo delle neuroscienze della connettività cerebrale con i modelli teorico-clinici della psicotraumatologia relazionale italiana. Partendo da un'analisi critica di un significativo studio neuroscientifico (Tsomokos, Rakesh et al., Psychological Medicine) che identifica alterazioni specifiche nella connettività della Default Mode Network (DMN) e della Rete Frontoparietale (FPN) in adolescenti esposti a minaccia sociale, questo articolo reinterpreta tali dati come la firma neurobiologica del trauma d'attaccamento. Sosteniamo che la ridotta connettività interna della DMN corrisponda alla frammentazione del Sé e alla dissociazione strutturale , mentre l'indebolimento della FPN sottenda la disregolazione emotiva cronica. L'iper-connessione anomala tra la DMN e le reti attentive esterne viene presentata come il correlato neurale dell'ipervigilanza e della vergogna tossica. Questi pattern neurali, considerati nel loro insieme, delineano l'architettura di un "cervello traumatizzato" che, incapace di auto-regolazione, è spinto a riattualizzare le dinamiche traumatiche infantili nelle relazioni adulte. Vengono discussi i concetti di "Paradosso del Partner" e "Bolla Traumatica" come esiti relazionali di questa impronta neurale. Infine, si delineano le implicazioni cliniche di tale modello integrato, sottolineando la necessità di interventi terapeutici bifocali ("top-down" e "bottom-up") finalizzati a ripristinare le capacità di auto-regolazione e a promuovere l'integrazione del Sé.
1. Introduzione: la grammatica neurobiologica del trauma relazionale
La psicotraumatologia contemporanea ha operato una distinzione fondamentale tra traumi "con la T maiuscola" (eventi singoli che minacciano l'integrità fisica) e traumi "con la t minuscola" (esperienze relazionali avverse e cumulative che minacciano l'integrità del Sé). È nel dominio del trauma relazionale che si radica la psicopatologia più complessa. Il modello della psicotraumatologia italiana postula che il trauma più pernicioso non sia l'evento avverso in sé, ma la sua occorrenza per mano di una figura di attaccamento, generando un paradosso biologico irrisolvibile. Come teorizzato da Giovanni Liotti, il bambino si trova intrappolato tra due sistemi motivazionali innati: l'attaccamento, che spinge alla ricerca di vicinanza, e la difesa, che impone la fuga dalla stessa figura che è fonte di terrore.
La soluzione adattativa a questo paradosso è la dissociazione, una frattura nei processi di integrazione che porta alla compartimentalizzazione dell'esperienza in stati del Sé "me" e "non-me". Questa "grammatica del trauma" non è una metafora, ma un vero e proprio algoritmo neurobiologico che programma le regole per la percezione della minaccia e la regolazione affettiva. Le neuroscienze confermano che tali esperienze alterano l'architettura dei circuiti neurali, spostando il focus da un modello di "lesione" a uno di "sviluppo alterato": il cervello non ha un trauma, diventa un cervello traumatico. Un recente studio sulla connettività cerebrale in adolescenti che percepiscono il proprio ambiente come pericoloso offre un'opportunità senza precedenti per visualizzare questo algoritmo in azione.
21 NOVEMBRE 2025 – QUESTURA DI ROMA.
PREVENZIONE DELLA VIOLENZA: L'APPROCCIO BASATO SULLE EVIDENZE E ORIENTATO AL TRAUMA, DALLA VITTIMA ALL'AUTORE
Quando e Dove:
- Data: 21 novembre 2025
- Orario: 09:30 – 12:30
- Location: Sala Conferenze "A. Cocola", presso la Questura di Roma, via di San Vitale 15.
Assicura il tuo posto per questo evento formativo unico, ospitato dalla Questura di Roma. I posti sono limitati.
EVENTO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. POSTI LIMITATI.
Per iscriversi scarica la scheda cliccando sul link: scheda iscrizione
2. Analisi dello studio neuroscientifico di riferimento
Lo studio di Tsomokos, Rakesh e colleghi ha esaminato un campione di quasi 8.700 adolescenti, correlando la percezione di minaccia sociale (a casa, a scuola, nel quartiere) a 10 anni con specifici pattern di connettività cerebrale a riposo. Dal nostro punto di vista, la "minaccia sociale percepita" è la misura diretta dell'attivazione cronica e irrisolta del sistema di attaccamento in un contesto insicuro, nucleo del trauma evolutivo.
I risultati hanno evidenziato due alterazioni principali:
- Ridotta connettività intra-rete: Una comunicazione interna indebolita all'interno della Default Mode Network (DMN), associata al pensiero auto-referenziale, e della Rete Frontoparietale (FPN), implicata nel controllo esecutivo.
- Aumentata connettività inter-rete: Una maggiore comunicazione tra reti normalmente separate, in particolare tra la DMN e la Rete dell'Attenzione Dorsale (DAN), orientata al monitoraggio esterno.
Questi cambiamenti, che predicono lo sviluppo di successivi problemi internalizzanti (ansia, depressione), supportano un modello in cui l'impronta neurale del trauma precede e media l'esito psicopatologico. È emerso inoltre che, sebbene il conflitto familiare fosse il più forte predittore della patologia futura, era l'insicurezza del quartiere ad associarsi più strettamente alle alterazioni neurali. Interpretiamo questo dato come un processo a due tempi: il conflitto familiare scrive il codice della vulnerabilità neurobiologica, mentre la minaccia ambientale cronica esegue e solidifica quel codice, rendendolo un pattern di connettività stabile e misurabile.
Ascolta il podcast sul Canale AIPC Editore su Spotify MENTE|CRIMINE|TRAUMA,“L'Impronta neurale del trauma relazionale: una rilettura neuroscientifica attraverso il modello della psicotraumatologia italiana", clicca sul link: https://open.spotify.com/episode/4UkdxWfapq7NZv7i38EVNT?si=RWboLk21SEWgmpf-II0zMA
3. Discussione: mappatura tra dati neurobiologici e costrutti psicotraumatologici
L'analisi integrata dei dati neuroscientifici e dei principi della psicotraumatologia relazionale permette di costruire una mappatura coerente tra i due domini.
3.1. La DMN e il sé frammentato
La DMN è l'infrastruttura neurale del Sé narrativo e coeso. La ridotta connettività al suo interno, osservata nei giovani esposti a minaccia, è la firma neurobiologica di un Sé non integrato, la controparte fisica della dissociazione strutturale. Una DMN le cui componenti comunicano in modo inefficiente è un cervello che fatica a costruire un'immagine unitaria di sé, base biologica della coesistenza di parti "me" e "non-me". Questa disconnessione spiega i deficit nella memoria autobiografica e nella mentalizzazione, tratti distintivi del trauma complesso.
L'aspetto più rivelatore, tuttavia, è l'iper-connessione tra la DMN (Sé) e la DAN (minaccia esterna). Questa fusione anomala è il meccanismo neurale che sottende la vergogna tossica. In un cervello traumatizzato, ogni atto di auto-riflessione ("chi sono io?") è inseparabile dal monitoraggio del pericolo ("sono in pericolo?"), fondendo l'identità con la minaccia. Il fallimento del caregiver viene interiorizzato come prova della propria indegnità ("è colpa mia"), creando un'associazione indelebile tra l'identità e il pericolo.
3.2. La FPN e l'Architettura dell'Insicurezza Cronica
La ridotta connettività interna nella FPN, un sistema cruciale per la regolazione top-down delle emozioni, è la base neurale della disregolazione emotiva e dell'impulsività. Un sistema di controllo esecutivo inefficiente non riesce a modulare le risposte subcorticali di allarme, lasciando l'individuo in balia di reazioni emotive intense e incontrollate. Questa organizzazione cerebrale "meno distinta" riflette un sistema nervoso che ha perso la flessibilità, bloccato in uno stato di ipervigilanza e/o collasso dissociativo, come descritto dalla Teoria Polivagale. Questo quadro corrisponde alla nostra descrizione del "cervello traumatizzato": un sistema che ha perso la capacità di distinguere tra sicurezza e pericolo, fissandosi in una modalità operativa difensiva.
3.3. Dalla disorganizzazione infantile alla "bolla traumatica" adulta
L'architettura neurale descritta — Sé frammentato, deficit di regolazione e ipervigilanza cronica — definisce ciò che chiamiamo il "cervello co-dipendente". Incapace di auto-regolazione, questo cervello è spinto a cercare compulsivamente un "regolatore esterno" per gestire l'angoscia. Questa spinta guida la scelta del partner secondo il "paradosso del partner": la ricerca inconscia non di un partner "sano", ma di uno la cui "ferita complementare" risuoni con la propria architettura traumatica.
Il sistema diadico che ne risulta è la "bolla traumatica", uno spazio di coppia isolato e autoreferenziale che funziona come una "camera dell'eco" del trauma. I partner si usano a vicenda come protesi per la regolazione, ma in un modo che riattiva continuamente i circuiti della minaccia. La bolla offre una prevedibilità che, per quanto dolorosa, è neurobiologicamente meno costosa del caos. Funziona come un "termostato traumatico" che mantiene il sistema in una zona tossica ma familiare, spiegando la profonda resistenza al cambiamento.
3.4. Integrazione tra rilievi neuroscientifici e costrutti psicotraumatologici
L'integrazione tra le scoperte neuroscientifiche e i modelli clinici permette di stabilire una mappatura diretta. Un primo rilievo è la ridotta connettività interna nella Default Mode Network (DMN). Questa alterazione, interpretata come una compromissione dei processi auto-referenziali, costituisce la base neurale per un Sé frammentato e la dissociazione, ed è associata a concetti come la dissociazione strutturale, gli stati del Sé "me/non-me" e il deficit di mentalizzazione.
Analogamente, la ridotta connettività interna nella Rete Frontoparietale (FPN) corrisponde a un deficit nelle funzioni esecutive, base della disregolazione emotiva e dell'impulsività. Un terzo dato cruciale è l'aumentata connettività tra la DMN e la Rete dell'Attenzione Dorsale (DAN). Questa anomalia riflette uno stato di ipervigilanza cronica e la fusione tra identità e minaccia, fondamento della vergogna tossica e del "cervello traumatizzato".
Infine, il fatto che queste alterazioni neurali siano predittive di sintomi futuri supporta il modello secondo cui l'impronta neurobiologica del trauma è la vulnerabilità per la sua riattualizzazione. A questo livello si collocano concetti integrati come il C-PTSD, la "Bolla Traumatica" e il "Cervello Co-dipendente".
4. Conclusioni e implicazioni cliniche
L'integrazione tra le scoperte neuroscientifiche e il modello della psicotraumatologia relazionale italiana delinea una catena causale che va dal trauma d'attaccamento all'impronta neurale e alla sua riattualizzazione nelle relazioni adulte. Questo offre una validazione empirica ai costrutti clinici sviluppati dal nostro gruppo di lavoro (AIPC, CIPR).
Le implicazioni per la pratica clinica sono profonde:
- Necessità di un approccio bifocale: È indispensabile un intervento integrato che agisca in modalità "top-down" (lavorando sulla narrazione e la mentalizzazione) e "bottom-up" (mirando alla regolazione del sistema nervoso attraverso tecniche come biofeedback, EMDR e approcci corporei).
- Obiettivo terapeutico: "rompere la bolla": L'obiettivo primario è aiutare i partner a passare da una dipendenza da un "regolatore esterno" disfunzionale allo sviluppo di capacità di auto-regolazione individuale. Neurobiologicamente, ciò significa rafforzare la connettività interna della FPN e della DMN di ciascun individuo.
- Il Ruolo del terapeuta: Il terapeuta agisce come un "regolatore esterno sano" e una "base sicura" surrogata. Attraverso una relazione terapeutica sicura, offre al sistema nervoso del paziente nuove esperienze intersoggettive capaci di rinegoziare i pattern neurali disfunzionali, promuovendo l'integrazione del Sé e aprendo la strada a una vita relazionale non più governata dalla grammatica del trauma, ma dalla possibilità della guarigione.
Bibliografia selezionata sulla psicotraumatologia relazionale
La seguente bibliografia si concentra sui lavori che fondano e approfondiscono il modello di psicotraumatologia relazionale descritto nell'articolo, con un focus sui contributi italiani.
Opere fondamentali e contributi teorici
Questa sezione include i lavori che hanno posto le basi per la comprensione del trauma d'attaccamento e della dissociazione.
- Liotti, G. (1992). Disorganized/Disoriented attachment in the etiology of dissociative disorders. Dissociation, 5, 196-204.
- Questo articolo è uno dei primi lavori seminali in cui Liotti collega direttamente l'attaccamento disorganizzato osservato nell'infanzia con lo sviluppo dei disturbi dissociativi in età adulta, un concetto centrale nell'articolo.
- Liotti, G., & Farina, B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Raffaello Cortina Editore.
- Opera fondamentale che sistematizza il pensiero di Liotti sul trauma, la dissociazione e le loro implicazioni cliniche, offrendo un quadro completo della teoria dell'attaccamento in chiave evolutivo-traumatica.
- van der Hart, O., Nijenhuis, E. R., & Steele, K. (2006). Fantasmi nel sé. Trauma e trattamento della dissociazione strutturale. Raffaello Cortina Editore.
- Sebbene non citato direttamente, questo testo è cruciale per comprendere la teoria della dissociazione strutturale della personalità (parti "me" e "non-me") a cui l'articolo fa riferimento.
Contributi di Lattanzi e Calzone (AIPC/CIPR)
Questa sezione elenca articoli e pubblicazioni che sviluppano i modelli clinici del "cervello co-dipendente", del "Paradosso del Partner" e della "Bolla Traumatica".
- Lattanzi, M., & Calzone, T. Articoli Vari su "Bolla Traumatica" e "Paradosso del Partner". Pubblicati su www.associazioneitalianadipsicologiaecriminologia.it.
- Descrizione: Attraverso numerosi articoli e report, Lattanzi e Calzone hanno introdotto e sviluppato i modelli della "Bolla Traumatica" come camera dell'eco del trauma nella coppia e del "Paradosso del Partner" come riedizione del paradosso del caregiver di Liotti in ambito adulto. Questi scritti, disponibili sul sito AIPC, rappresentano la fonte primaria per la comprensione di tali costrutti.
- AIPC Editore. Pubblicazioni e Atti di Convegni su Trauma e Violenza.
- Descrizione: L'attività editoriale dell'AIPC include la pubblicazione di ebook, sintesi di seminari (es. "Trauma e Violenza") e libri (es. "Sedie Bianche") che raccolgono gli esiti di ricerche e interventi clinici del gruppo di lavoro del CIPR e dell'ONOF, spesso a cura di Lattanzi e Calzone.
- CIPR (Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale). Webinar e Materiali Formativi.
- Descrizione: Il CIPR diffonde il proprio modello attraverso eventi formativi, come i webinar sulla psicotraumatologia relazionale, in cui vengono illustrati i fondamenti neurobiologici (es. Teoria Polivagale) e clinici del loro approccio al trauma complesso.
Articoli e risorse online (dal sito AIPC)
Il sito dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia funge da archivio principale per i lavori del gruppo di ricerca.
- Lattanzi, M., & Calzone, T. (2025). La bolla traumatica e il paradosso del partner di Lattanzi e Calzone, la riattualizzazione del trauma nella coppia. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
- Questo articolo specifico, citato nei risultati di ricerca, è un esempio chiave di come i concetti vengono articolati e presentati al pubblico professionale, collegando direttamente il trauma infantile alle dinamiche di coppia adulte.
- Calzone, T., Ventura, C., & Lattanzi, M. Report Settimanali dell'Osservatorio Nazionale Omicidi Familiari (ONOF). Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
- I report dell'ONOF, come quello sul "Partnericidio", applicano il modello della psicotraumatologia relazionale all'analisi di casi reali di violenza, fornendo dati e interpretazioni cliniche che sostanziano la teoria del trauma d'attaccamento come matrice della violenza.
- AIPC/CIPR. (2025). Psicotraumatologia relazionale: il ciclo della violenza. Settimana del Cervello 2025. Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
- Articolo che riassume gli interventi e i concetti presentati durante eventi di divulgazione scientifica, mostrando l'impegno nel connettere le scoperte delle neuroscienze con la pratica clinica.